Pedagogia
Il trenino fonda il proprio agire educativo attraverso una pedagogia mista traendo spunto da differenti pensieri, filosofie e correnti pedagogiche attraverso i quali ogni struttura ha potuto elaborare il proprio orientamento teorico a cui fare riferimento.

La persona di riferimento
Nello specifico, il rimando preponderante per delineare le pratiche pedagogiche attuate è il concetto di persona di riferimento, elaborato e messo a punto da Elinor Goldschmied[1], che all’interno dei servizi diventa anche il valore attorno alla quale viene gestita l’intera organizzazione. Esso prevede che ogni bambino/a, già dopo il primo contatto con il servizio, abbia una persona di riferimento, ovvero un’educatrice che non sia intesa come unica riconosciuta, bensì come adulto che garantisce un ambiente sicuro e protetto per permettere la creazione di una relazione privilegiata e di fiducia, sia con il piccolo che con la famiglia. E’ questa figura educativa che si occupa di accompagnare il bambino/a durante i momenti cruciali della giornata, come ad esempio i pasti, il cambio, la siesta, attraverso un intervento individuale nel totale rispetto della singolarità di ognuno.
[1] Elinor Goldschmied (1910-2009), educatrice e pedagogista britannica. I suoi studi e le sue ricerche hanno contribuito a creare l’apparato moderno della psicopedagogia concentrandosi soprattutto sullo sviluppo infantile.
La pedagogia della relazione
Il secondo costrutto teorico al quale ci si aggancia e che si realizza concretamente grazie alla figura di riferimento, è la pedagogia della relazione, che considera la relazione l’elemento cardine del fare e dell’essere al nido.
Il nido diventa, quindi, il suo essere luogo in cui si instaurano e si coltivano relazioni affettive fra adulti, fra adulti e bambini/e e fra pari. Il bambino/a ha una propria soggettività, ma anche una predisposizione innata alla socialità e pertanto necessita di rapporti e legami forti, stabili e coerenti per evolvere, per orientarsi, per esplorare e mettersi alla prova pur sentendosi protetto e contenuto. La qualità della relazione dipende dalle caratteristiche caratteriali di ognuno sommate alle emozioni, alle disposizioni affettive e ai sentimenti messi in campo negli scambi reciproci e pertanto sono proprio questi elementi a rendere un legame unico e irripetibile.
L’educatore, quindi, è il perno di tutte le relazioni all’interno del Nido d’infanzia, in quanto si trova a dover mediare una separazione del bambino/a dal proprio caregiver con il compito di ricreare un legame di fiducia rispettivamente con l’uno e con l’altro per fare in modo che l’esperienza al nido risulti piacevole e costruttiva per tutti gli attori in questione.
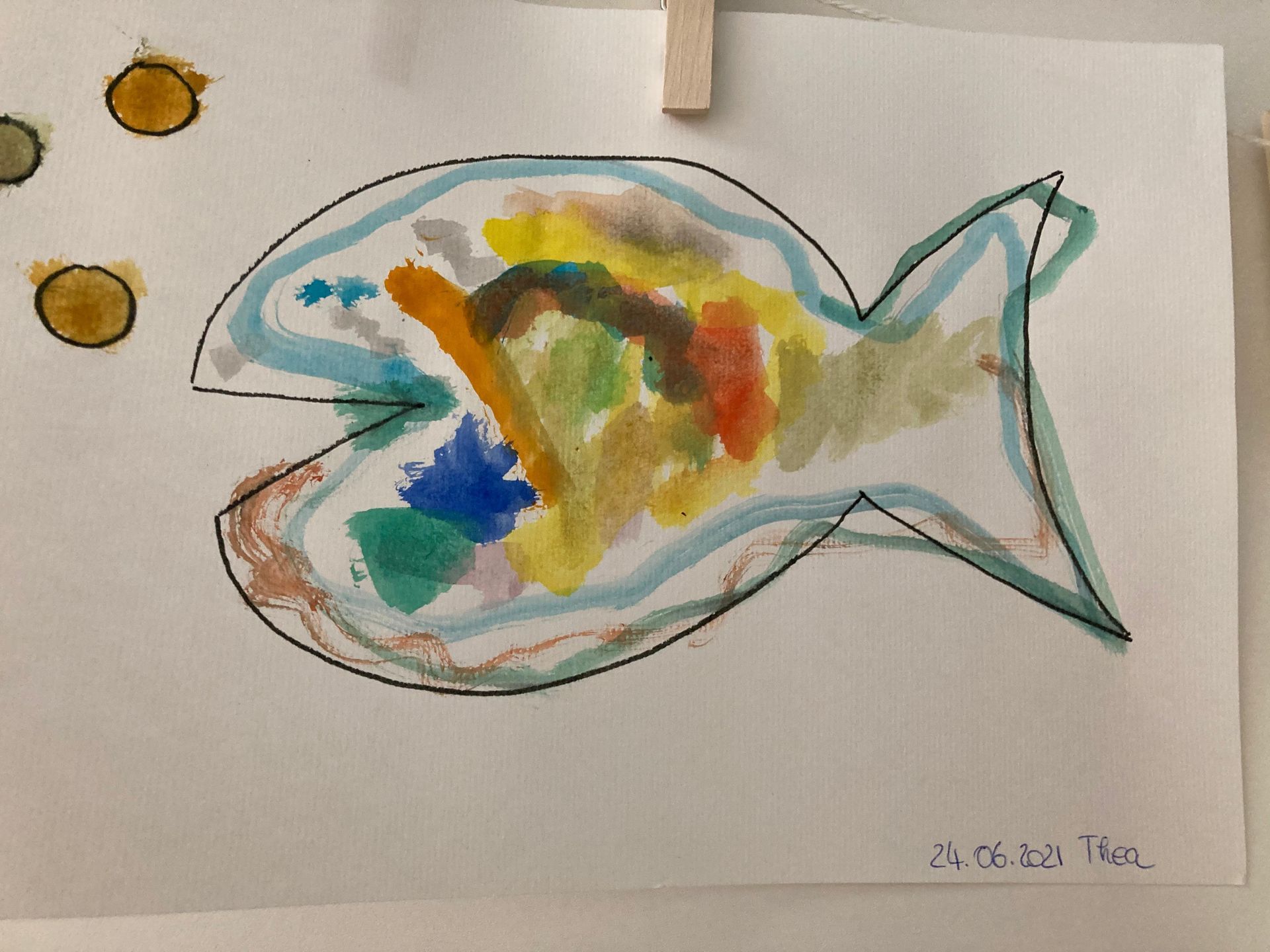

L’autonomia pratica ed emotiva
La nostra progettualità educativa è arricchita anche dal pensiero pedagogico di
Maria Montessori: secondo l’idea montessoriana ogni bambino possiede, sin dalla nascita, competenze, potenzialità e abilità innate che, se adeguatamente sostenute, gli permettono di essere artefice attivo del proprio sviluppo e costruttore della propria personalità. In questa prospettiva, l’ambiente educativo viene organizzato in modo funzionale all’esercizio dell’autonomia pratica ed emotiva, attraverso spazi accessibili, strutturati a misura di bambino e dotati di materiali variati e selezionati sulla base dei loro interessi. Tali materiali vengono periodicamente rinnovati per stimolare la curiosità, l’autodeterminazione e il senso di competenza, in un contesto che promuove rispetto, libertà responsabile e crescita armoniosa.
Giochi e spazi
All’interno della struttura si promuove ampiamente l’autonomia pratica ed emotiva, offrendo spazi strutturati, a loro misura e quindi accessibili, con materiali diversificati (scelti sulla base dei loro interessi) che vengono settimanalmente cambiati, in modo da favorire il più possibile la sua autodeterminazione e il rispetto di sé. La maggior parte del materiale messo a disposizione negli spazi si presenta all’interno di un contenitore (vassoio in legno, cestino, scatola, …) per aiutare il bambino ad avere un contenimento e favorire la sua concentrazione. Si cerca quindi di predisporre un ambiente che “parli” per invitare il bambino/a a sperimentare quante più esperienze possibili, lasciandolo libero di decidere cosa desidera fare e per quanto tempo, provare, sbagliare, autocorreggersi e quindi apprendere. In tutto questo processo l’adulto, avendo progettato l’ambiente di vita minuziosamente e dopo un’accurata osservazione, cerca di intervenire il meno possibile nel processo di costruzione di conoscenza del mondo e di se stesso del bambino/a.

